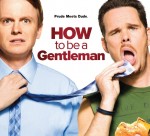How to be a gentleman di Diego Castelli
Nell’annuale infornata di comedy, non tutte le ciambelle riescono col buco
Ormai da tempo ho una specie di complesso di inferiorità nei confronti del Villa. Lui è così forte e vigoroso, privo di remore, e distrugge senza pietà i telefilm più impensabili, dimostrando ben poco timore dell’opinione comune. Io invece sono più pacioso e accondiscente, e tendo a vedere del buono praticamente in tutte le serie in cui mi imbatto.
Fortunatamente, a ridurre la distanza tra di noi è arrivato How to be a gentleman. Perché How to be a gentleman è brutto. Anzi, è inutile, che forse è peggio.
Il concept è abbastanza semplice. Andrew, un uomo vecchio stile, di quelli sempre ben vestiti, educati, attenti all’etichetta, si guadagna da vivere scrivendo sulla rubrica di un giornale, attraverso la quale insegna, appunto, a essere dei perfetti gentiluomini. Quando la casa editrice decide di dare una svolta alla rubrica, rendendola più giovane e sexy, Bert rimane spiazzato, e per non perdere il posto deve farsi aiutare da Bert, ex compagno di scuola nonché bullo, che ora è diventato il rozzo gestore di una palestra, ma che può anche insegnarli a essere un uomo moderno, cioè un po’ più primitivo…
 Malgrado l’idea sia tutto sommato carina, in How to be a gentleman non funziona quasi niente. Il che non è mica facile, a pensarci bene.
Malgrado l’idea sia tutto sommato carina, in How to be a gentleman non funziona quasi niente. Il che non è mica facile, a pensarci bene.
Non funziona la messa in scena, vecchia e banale, con ambientazioni scarne e poco accattivanti e un gusto retrò che a chiamarlo “gusto retrò” gli si fa un favore, perché la parola giusta sarebbe “vecchiume”.
Non funziona la scrittura, che alterna poche battute vagamente decenti a troppi momenti di comicità lenta e scialba (quando Bert scherza dicendo che il padre ha avuto un “tumore al pene”, pare quanto mai evidente che lo sceneggiatore cercava solo un modo per inserire la parola “pene” nel copione).
Non funziona Kevin Dillon, che dà vita a un Bert troppo poco incisivo, eccessivamente buono, se volete, rispetto all’idea che lo spettatore sia era fatto anche solo leggendo la trama. Senza contare che, purtroppo per lui, non si può guardare in faccia Kevin Dillon senza pensare che assomiglia a Matt, ma non è Matt. Un po’ come per i mille mila fratelli di Alec Baldwin.
Stranamente, non funziona Mary Lynn Rajskub, che interpreta Janet, sorella di Andrew: dico stranamente perché l’ex Chloe di 24 nasce proprio come comica, e attendevo con ansia di vederla nel suo vero ambiente, invece che dietro le scrivanie del CTU. Ebbene, anche lei finisce nel pantano della mediocrità, senza regalare praticamente alcun momento memorabile.
L’unico a salvarsi, forse, è Rhys Darby, che qualcuno ricorderà da film come I Love Radio Rock e Yes Man: il suo Mike, marito di Janet, riesce a strappare qualche risata grazie a una mimica e una gestualità sufficientemente imbecilli, e una buffa sottomissione nei confronti della moglie despota.
Ma al di là di tutti questi problemi, che potrebbero essere facilmente risolti investendo qualche soldo in più, cambiando sceneggiatori, metà abbondante del cast e il ragazzo che porta i caffè sul set, c’è proprio una questione di fondo che è quasi irrisolvibile, e che riguarda il protagonista.
Andrew, nel suo mondo, è una specie di Sheldon Cooper. Come lui è un disadattato, un diverso, uno che ha pochissimi amici perché è impegnato a dare un sacco di importanza a cose che per gli altri sono del tutto superflue. Tuttavia, al di là delle differenze più macroscopiche e scontate  (Sheldon è venuto prima, è interpretato da un attore più bravo, e gli mettono in bocca battute pià divertenti), ce n’è una pià nascosta e fondamentale: in Sheldon, malgrado tutto, ci si può identificare. The Big Bang Theory ha portato alla luce della ribalta una categoria, quella del nerd, che è fittamente popolata, con diversi livelli di sfumature. E’ chiaro che Sheldon è un’esagerazione, ma anche il mondo reale è pieno di ragazzi appassionati di videogiochi, fumetti, fantascienza e giochi di ruolo, che capiscono la comicità del dottor Cooper e la sentono in qualche modo “propria”. Così come è pieno di persone che quei nerd li conoscono, o che comunque partecipano in qualche misura a certe loro piccole follie. A tutti, chi più chi meno, capita di fare ragionamenti strambi pensando al posto migliore per sedere sul divano; tutti prima o poi fanno i saputelli su un argomento che conoscono solo loro e di cui non frega niente a nessuno; tutti hanno provato ad adocchiare la vicina di casa/banco/ufficio che ritenevano al di fuori della propria portata, in quanto troppo bella o troppo glamour o che so io.
(Sheldon è venuto prima, è interpretato da un attore più bravo, e gli mettono in bocca battute pià divertenti), ce n’è una pià nascosta e fondamentale: in Sheldon, malgrado tutto, ci si può identificare. The Big Bang Theory ha portato alla luce della ribalta una categoria, quella del nerd, che è fittamente popolata, con diversi livelli di sfumature. E’ chiaro che Sheldon è un’esagerazione, ma anche il mondo reale è pieno di ragazzi appassionati di videogiochi, fumetti, fantascienza e giochi di ruolo, che capiscono la comicità del dottor Cooper e la sentono in qualche modo “propria”. Così come è pieno di persone che quei nerd li conoscono, o che comunque partecipano in qualche misura a certe loro piccole follie. A tutti, chi più chi meno, capita di fare ragionamenti strambi pensando al posto migliore per sedere sul divano; tutti prima o poi fanno i saputelli su un argomento che conoscono solo loro e di cui non frega niente a nessuno; tutti hanno provato ad adocchiare la vicina di casa/banco/ufficio che ritenevano al di fuori della propria portata, in quanto troppo bella o troppo glamour o che so io.
E guardate che questo processo di immedesimazione è alla base di un sacco di comedy di successo, dove ci fanno vedere le beghe tra uomini e donne, tra genitori e figli, tra mariti e mogli.
In How to be a gentleman, invece, anche la più piccola immedesimazione è resa assai difficoltosa. Perché se i nerd al mondo sono tanti, più di quanto si pensi, e quasi tutti amano guardare le sitcom, così non è per gli aspiranti gentiluomini, che anche se esistono sono molti di meno, e comunque invece di guardare la tv vanno in barca, o bevono liquore, o altro, io che ne so, sono un nerd!
Alla fine, lo spettatore di How to be a gentleman si ritrova a guardare una serie lenta, loffia, girata in modo banale, con personaggi poco interessanti e una grossa difficoltà a fare quel piccolo ma importantissimo ragionamento inconscio: “guarda quanto sono buffe queste  persone, ma in fondo vedo che in qualcosa sono simili a me”.
persone, ma in fondo vedo che in qualcosa sono simili a me”.
Risultato: si cambia canale.
Previsioni sul futuro: Andrew continuerà a farsi aiutare da Bert, che gli darà nuovi imperdibili spunti trash per la sua rubrica, e intanto gli insegnerà a essere meno rigido e un po’ più umano.
Perché seguirlo: Ehhhh, dunque… scusate, squilla il telefono.
Perché mollarlo: credo di poter dire che tutte le altre comedy attualmente in onda sono migliori.
.
.
.
.